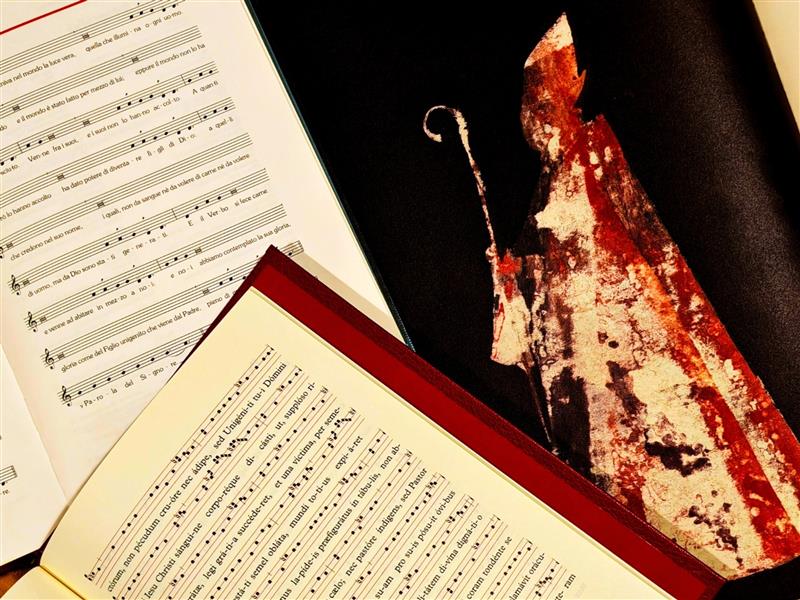Appartenente alla tipologia ambrosiana, cioè dotato di teca cilindrica, l’ostensorio pontificale è un prezioso manufatto in argento dorato e smaltato e cristallo di rocca: eseguito in Lombardia alla fine del Cinquecento ed entrato nel Tesoro del Duomo, si trova oggi esposto in Museo nella sezione dedicata appunto al Tesoro (sala n. 2).
Incluso negli oggetti liturgici propri del vescovo, come specificato dal termine “pontificale”, nella prima metà dell’Ottocento l’ostensorio era impiegato per l’esposizione del Santissimo Sacramento durante le Quaranta Ore e l’Ottava del Corpus Domini.
Il manufatto si presenta sorretto da un piede rettangolare, con lati brevi ellittici, gradino traforato e sagomato; il sostegno appare inoltre ornato da una complicata lavorazione a giorno su un fondo d’argento, raffigurante trionfi eucaristici con spighe e uva tra volute schematizzate.
Il nodo a vaso, in cristallo di rocca, è rivestito da una griglia d’argento dorato, con dettagli decorativi in smalto simulanti gemme rosse in castone: dettagli simili si osservano sia sulla base della campana a calice, con corolla di foglie a volute e due teste di serafino, sia sulla cornice dell’architrave.
La campana di cristallo, ellittica e contenente una lunetta reggi-ostia a forma di teste cherubiche alate, è inquadrata da due sottili lesene a erma, mentre sui quattro spicchi che compongono il coperchio di cristallo di rocca sono incisi simboli della Passione (croce, corona di spine, sacra Sindone, spugna, lancia, scala, corona con croce, gallo, tenaglia e martello, flagello e sciabola).
Conclude superiormente l’opera un fastigio a croce greca (forse ottocentesca) dai bracci quadrilobi traforati, su base composta da fogliette con due spighe.
Inquadrato dagli studiosi nell’ambito della produzione lombarda tardo rinascimentale di gusto tipicamente manieristico, è molto probabile che l’ostensorio sia stato eseguito a Milano, centro indiscusso per la lavorazione del cristallo di rocca tra XVI e XVII secolo le cui botteghe realizzano opere completate da legature smaltate, talvolta impreziosite da motivi imitanti gemme rosse incastonate come in questo caso.
Nello specifico, per le parti orafe è stata suggerita la mano di un maestro che “italianizza” le griglie con intrecci geometrico-vegetali tipici della produzione dell’orafo tedesco Wenzel Jamnitzer, caratterizzata da vasi con nodi ovaliformi rivestiti da decori a giorno e sostegni espansi e schiacciati.
Anche le grandi volute appiattite che incorniciano le finte gemme hanno rimandi a oreficerie d’oltralpe (Augusta, o in generale, sud della Germania): orafi tedeschi lavorano del resto a Milano durante il Rinascimento, come per esempio Giovanni Molinari ed Erman Doncal.