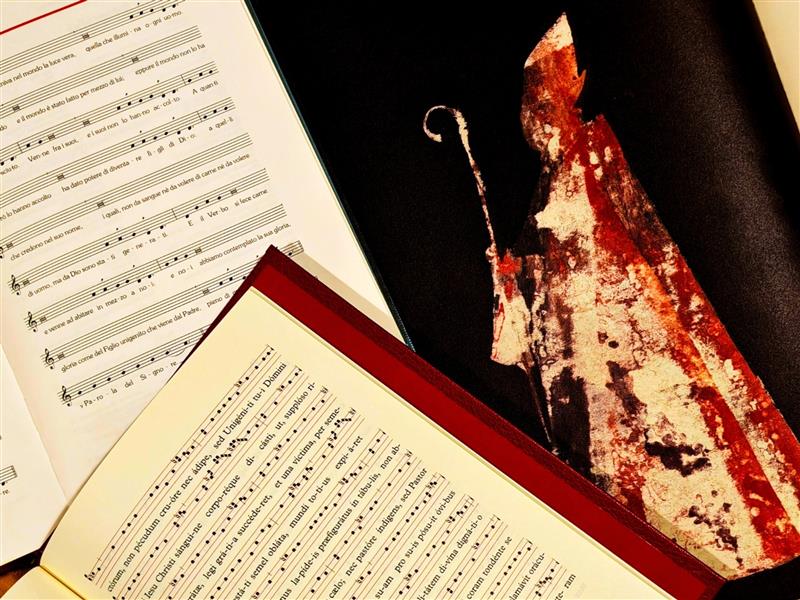Raffigurante “Sant’Apollonia” e databile al 1854, il modello in terracotta patinata fu realizzato come prova preparatoria per una scultura marmorea di stesso soggetto (1856), destinata a decorare la nicchia destra dell’altare di Sant’Agata in Duomo e tuttora in loco.
Il modello, oggi esposto nella sala del Museo dedicata all’Ottocento (n. 17), fu eseguito come la statua in marmo da Benedetto Cacciatori: originario di Carrara e trasferitosi nel 1810 a Milano per i lavori dell’Arco della Pace, egli s’iscrisse all’Accademia di Brera e iniziò la sua attività per la Cattedrale nel 1823, terminandola quasi quarant’anni più tardi.
Scultore di fiducia dei Savoia nonché titolare della cattedra di scultura a Brera dal 1853, nella sua produzione Cacciatori non rinnegò mai la formazione neoclassica, anche se gli studiosi hanno evidenziato in essa una svolta naturalistica precisa e consapevole, dai tratti intimisti e vagamente romantici.
Nel modello per la “Santa Apollonia”, l’artista ritrae la vergine cristiana martirizzata nel III secolo ad Alessandria d’Egitto come una giovane fanciulla abbigliata con una tunica. Quest’ultima è coperta da un manto che riveste anche il capo, tramite un velo formante due nodi di tessuto ai lati.
Il viso appare ribassato e lo sguardo rivolto verso il simbolo del martirio, tenuto dalla santa nella mano destra: una ciotola con i suoi denti estirpati dai carnefici. L’altra mano, posta più in alto, stringe una piccola tenaglia, mentre la gamba corrispondente è leggermente incurvata e quella destra flessa.
Definita dagli studiosi uno dei più nobili esemplari della scultura ottocentesca lombarda in Duomo, dal punto di vista stilistico la “Sant’Apollonia” è una riuscita sintesi tra il classicismo accademico e il quattrocentismo purista tipici dell’arte di Cacciatori.
In particolare, la composizione risulta dominata da una raffinatezza evidente sia nel disegno magistrale dei panneggi sia nel senso di malinconica pensosità che pervade il volto della santa, ispirato a prototipi di Raffaello e del suo maestro Perugino.
L’opera appare inoltre influenzata dalle sculture di Vincenzo Vela, allievo di Cacciatori, e dalla pittura di Francesco Hayez: si veda per esempio la sua “Madonna con il Bambino e devota” (1851), esposta a Brescia presso i Musei Civici di Arte e Storia, Santa Giulia-Museo della Città.