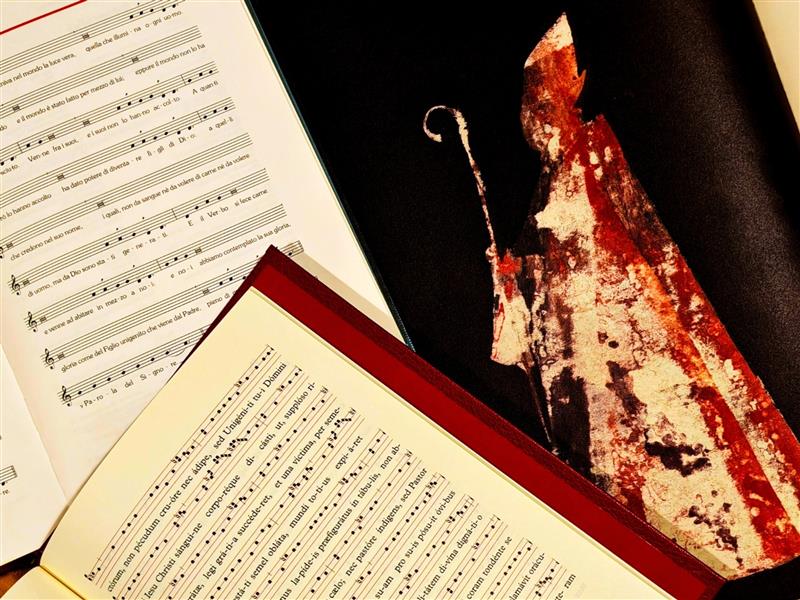Eseguito in argento sbalzato, cesellato e anche dorato, il calice di Pio IV prende il suo nome dal pontefice a cui appartenne (Giovanni Angelo Braschi, papa dal 1775 al 1799). Probabilmente realizzato all’inizio del Seicento, forse in Toscana, il prezioso manufatto fu donato al Capitolo del Duomo nel 1905 dall’arcivescovo Carlo Andrea Ferrari, e si trova oggi esposto in Museo all’interno di una delle sale dedicate al Tesoro (n. 2).
L’opera presenta un piede a sezione circolare, sul quale sono raffigurati a sbalzo tre santi (un martire e due monaci), alternati ad altrettante teste cherubiche; sul fusto spiccano invece le tre Virtù teologali (Fede, Speranza, Carità), intervallate da erme.
Il nodo a vaso, con lavorazione a giorno che lascia intravedere il fusto dorato, è caratterizzato da teste di cherubini e trofei: una lavorazione simile decora il sottocoppa, scandito da tre medaglie con l’Assunta, Cristo risorto e Cristo benedicente con il calice (personificazione della Chiesa), alternate a serafini.
Secondo l’iscrizione incisa sotto al piede, il calice fu usato a Siena il 27 maggio 1798 da papa Pio VI durante l’ultima messa prima della deportazione in Provenza, a seguito della proclamazione della Repubblica romana innescata dalla Rivoluzione francese.
Dal punto di vista stilistico, è stato osservato come l’ordinata soluzione ornamentale adottata per il piede sembri confermare la produzione in area toscana agli inizi del Seicento; tuttavia, la decorazione a traforo delle foglie in cui si inseriscono le teste cherubiche, che produce effetti chiaroscurali e contrasto di luce segnalando anticipazioni barocche, rimanda invece all’argenteria secentesca del centro Italia.
Si veda per esempio il calice nel Tesoro di San Pietro a Bologna, databile al pieno Seicento e assegnato a bottega romana con collegamento ad altri esemplari simili nelle chiese bolognesi di San Petronio e San Luca.