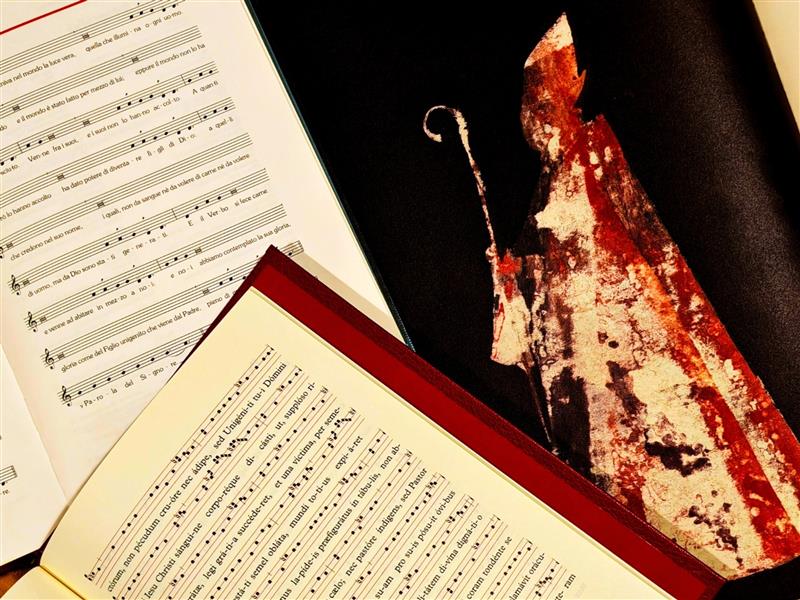Splendente d’oro, perle e pietre preziose, l’ostensorio Castiglioni appartiene almeno dalla fine del Cinquecento al Tesoro del Duomo: dal 2013 esso è esposto in Museo all’interno di una delle sale dedicate appunto al Tesoro (n. 2).
Progettato per esporre l’ostia consacrata o per portarla in processione, il prezioso manufatto prende il nome dalla nobile famiglia milanese dei Castiglioni, il cui stemma compariva in origine sulla base.
Probabilmente realizzato sul finire del Cinquecento da una bottega milanese, l’ostensorio presenta un fusto a sagoma di tronco d’albero nodoso, raccordato alla base (circolare e con perimetro formato da un ramo) tramite quattro radici cilindriche. Il piede è a sua volta composto da un fitto intreccio di rametti, decorati con foglie smaltate di verde e perle; il perimetro del sostegno appare invece ornato da quattro zaffiri incastonati.
Altre piccole foglie, accartocciate, formano una corolla che sostiene la teca a sezione ottagonale in cristallo di rocca, con la lunetta per il sostegno dell’ostia inquadrata da due angioletti incisi sulla superficie.
Il tema vegetale ritorna nella montatura in lastra d’oro, che sul basamento circolare mostra coppie di rami d’ulivo cesellati, e sul perimetro del coperchio in vetro: quest’ultimo è infatti segnato da un ramo simile a quello del sostegno, qui decorato da fogliette smaltate di verde, perle e quattro rubini incastonati.
Ulteriori foglie d’oro, in questo caso lanceolate e stilizzate, sono presenti sulla sommità del coperchio, dove si erge un globo in cristallo di rocca sormontato da una piccola croce dorata.
Gli studiosi hanno ipotizzato che il piedistallo sia stato riutilizzato capovolto per l’ostensorio: se girato, infatti, la corolla di fogliette accartocciate assume l’aspetto di radici, alcuni rami appaiono recisi verso l’alto mentre altri salgono a formare la chioma di foglie verdi smaltate, ricca di frutti e bacche di vischio. Considerando il significato beneaugurante di questi ultimi, è stato quindi immaginato che in origine il piedistallo appartenesse a una coppa nuziale.
Dal punto di vista stilistico, l’ostensorio risulta in linea con il neogoticismo caratterizzante le arti figurative nel ducato di Milano all’epoca di Ludovico il Moro, incluso il recupero in oreficeria di tecniche e motivi dei prodotti degli anni di Gian Galeazzo Visconti: in questo caso, l’impiego dello smalto traslucido sull’oro e i rametti con foglie e perle del basamento.
Proprio il naturalistico intreccio di ramoscelli e arbusti che contraddistingue l’ostensorio richiama quello immortalato da Leonardo da Vinci nei suoi celebri affreschi per la Sala delle Asse del Castello Sforzesco di Milano (1493-1499), eccezionale testimonianza della presenza del maestro toscano alla corte del Moro.