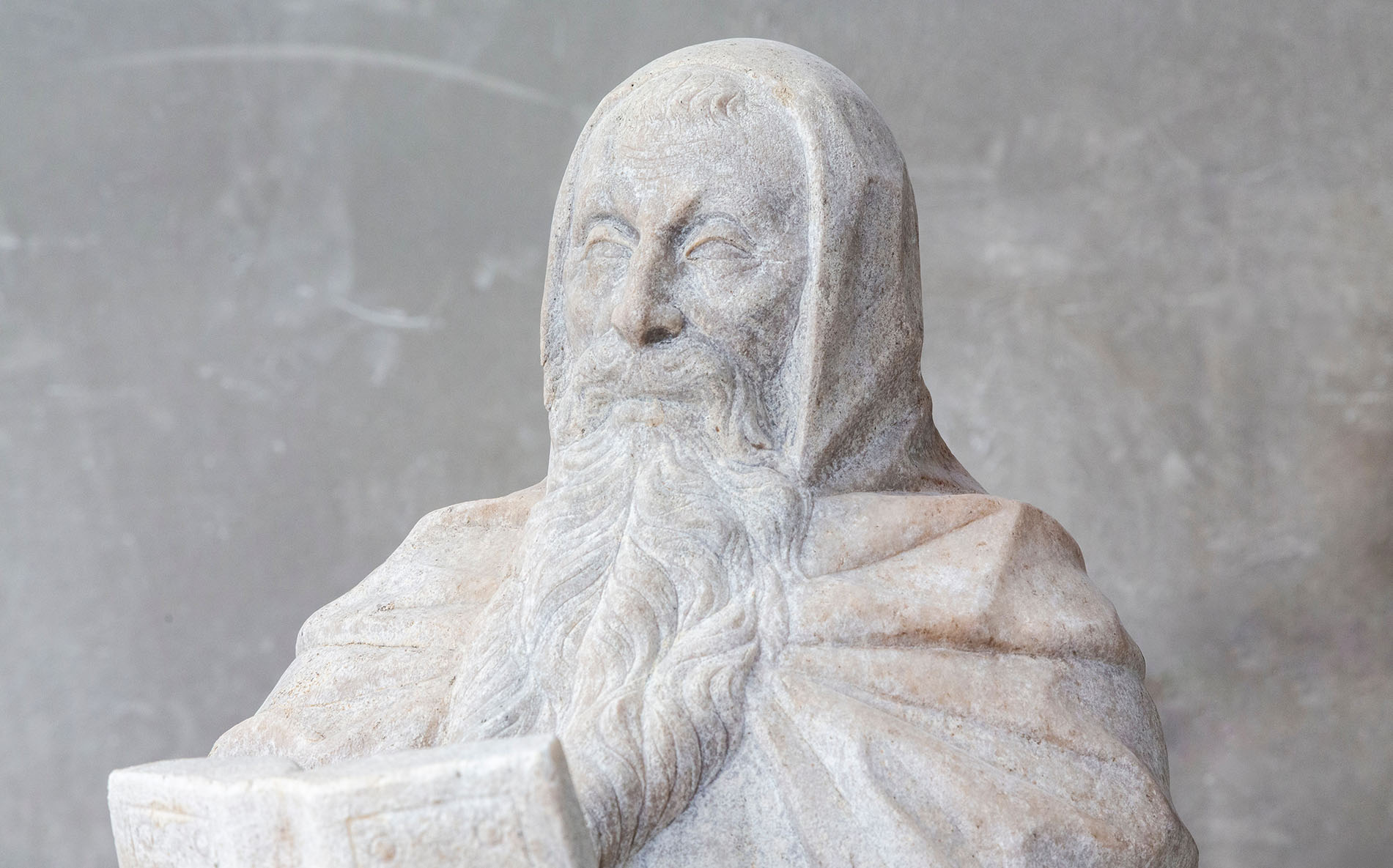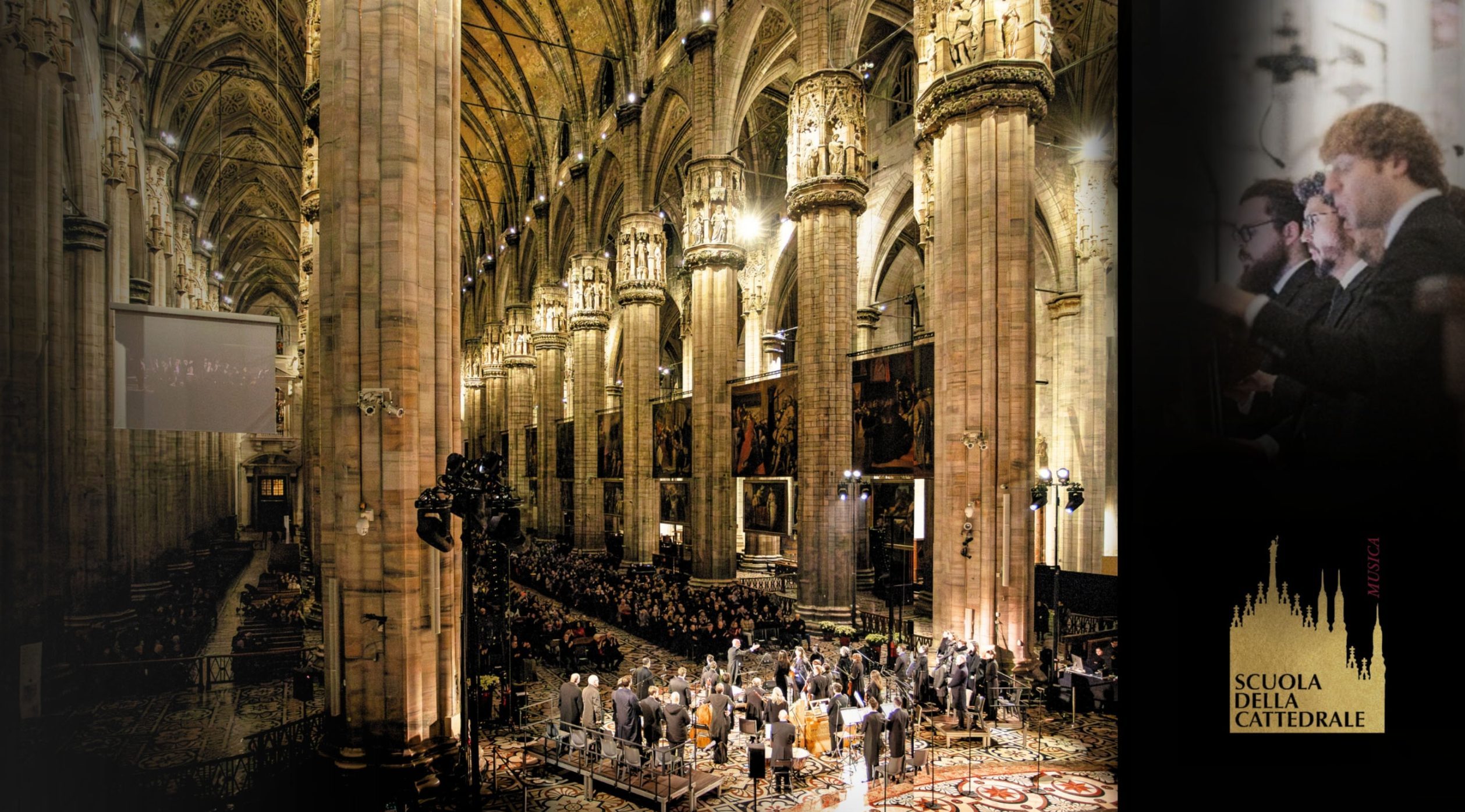Abbinati alle relative basi, i due piccoli capitelli (XV o XVI secolo) appartengono alla serie di pezzi lapidei erratici reimpiegati nei muri esterni del Duomo, trovati durante i restauri che nel 1939 interessarono le pareti del secondo ordine del terrazzo sul lato meridionale, in prossimità della facciata.
Ricavati da un solo blocco di pietra e oggi esposti in Museo nella sala dedicata alle origini della Cattedrale (n. 3), i due capitelli risultano uniti tra loro nella zona di tangenza, e sono caratterizzati da un unico giro di quattro spesse foglie su collarino: lisce e allungate, esse terminano con gonfi crochet, cioè decorazioni vegetali stilizzate che si rifanno alla tipologia classica reinterpretata secondo il gusto gotico.
Al centro, nella parte sottostante, sono posizionati i fori per l’alloggiamento dei perni in ferro necessari al fissaggio, uno dei quali si conserva sotto un capitello. Piuttosto consunti e scalfiti, entrambi gli elementi presentano i listelli corrispondenti al sottile abaco e al plinto di sezione rettangolare sbreccati lungo i profili e, in particolare, in corrispondenza degli angoli.
Inoltre, i due capitelli appaiono portati a livello di finitura e recano tracce di intonaco chiaro.
Inizialmente, la provenienza originaria dei capitelli e delle loro basi è stata ricondotta a Santa Maria Maggiore, l’antica basilica utilizzata durante i mesi invernali che, insieme a quella estiva di Santa Tecla, si trovava nell’area oggi occupata dal Duomo e dalla sua piazza. Attestata nel IX secolo e probabilmente ricostruita nel XII, Santa Maria Maggiore fu via via demolita con il procedere del cantiere della nuova Cattedrale, e la sua facciata divenne per due secoli quella provvisoria del Duomo, definitivamente abbattuta nel 1683.
Studi recenti affermano che le diverse riproduzioni a noi giunte di Santa Maria Maggiore, realizzate in marmo o restituite da miniature e dipinti fra Trecento e Seicento, non sono così curate nel dettaglio da consentire di confermare la provenienza dall’antica chiesa dei capitelli e delle basi.
Questi ultimi mostrano una fattura piuttosto rozza, condivisa con elementi architettonici molto diffusi nelle strutture del Quattrocento lombardo: probabilmente, le opere in questione erano parte di un insieme di colonnine binate di un chiostro, oppure contribuivano a comporre l’apertura di una loggia o di una finestra bifora.